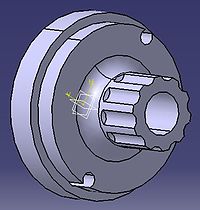Piegatura


La piegatura è una lavorazione meccanica con la quale si deforma un determinato oggetto applicandogli delle forze.
Insieme alla tranciatura ed allo stampaggio, la piegatura è una delle lavorazioni applicabili alla lamiera per ottenere semilavorati piani.
La piegatura viene utilizzata per ottenere determinate forme, ma anche per conseguire un irrigidimento della struttura. In ambito industriale è ottenuta tramite un'apposita macchina detta piegatrice, ma la prima tecnica di piegatura sfruttava incudine e martello.

Profili di piegatura
Si possono effettuare piegature a "U" o ad "V" a seconda che in corrispondenza della piegatura si presenti o meno un angolo di raccordo sufficientemente ampio. Lo stato di deformazione che si ottiene attraverso la piegatura può essere di sforzo uniassiale (nel caso di basso rapporto larghezza w / spessore b) o di deformazione piana (nel caso di w/b alto). La deformazione nella lamiera varia quindi in funzione della geometria del semilavorato.
È possibile definire una forza max applicabile:
Dove:
- è il limite di snervamento
- b è lo spessore
- w è la larghezza
- L è la lunghezza.
Da notare che nel processo di piegatura è necessario considerare il fenomeno del recupero elastico, che modifica l'angolo di piegatura ottenuto. Inoltre è fondamentale conoscere la direzione di laminazione del semilavorato, in quanto una piegatura in direzione perpendicolare a quella di lavorazione può portare alla formazione di cricche (perché il semilavorato è anisotropo).
Fattori di variabilità della lamiera
Quando si effettua una piega su una lamiera, si sta cercando di ottenere fondamentalmente due valori: X e α.
Ciascuno di essi corrisponde rispettivamente a
● X= la lunghezza della piega o “lunghezza di flangia”. In inglese viene chiamata flange;
● α= l’angolo di piegatura, cioè l’angolo compreso tra le due facce interne dei lembi piegati.
Y è una conseguenza che generalmente non dipende direttamente dall’operatore alla macchina, ma dalla qualità dello sviluppo della lamiera. Lo sviluppo rappresenta un oggetto piano con una forma e delle dimensioni ottimizzate affinché una volta piegato risulti conforme. Le componenti che entrano in gioco nel raggiungimento o nella ripetibilità dei valori X e α sono chiamate “fattori di variabilità”.[1]
I fattori principali di variabilità della lamiera sono:
- la finitura;
- la differenza di spessore;
- il senso di laminazione;
- la composizione chimica
- la temperatura.
Tipologie di piegatura
Piegatura in aria
Si tratta sicuramente della modalità più comune e diffusa e quella verso cui i costruttori si stanno dirigendo sempre più spesso. Prevede l’utilizzo di matrici e di punzoni aventi un’ampiezza V inferiore a 88°. Commercialmente sono frequenti punzoni a 60, 45, 35, 30° ma non solo. Le matrici più usate, invece, sono a 60, 45, o 30°.
La caratteristica principale è che il pezzo viene piegato “in sospensione”, senza, quindi, adagiarsi in nessun modo sul fondo della matrice. Tra i vantaggi c’è senza dubbio la grande versatilità che offre. Consente, infatti, di eseguire pieghe con angoli ottusi o acuti senza cambiare attrezzaggio.
Piegatura a fondo matrice
Chiamata anche “semi-coniatura” o “a fondo cava”, è la modalità che si ottiene utilizzando matrici da 88°. In questo caso la lamiera arriva al fondo della matrice entrando in contatto con le facce interne della V. Il naturale ritorno elastico fa sì che la piega ottenuta risulti essere di 90°. I raggi interni di piegatura naturalmente scaturiti risultano essere leggermente più piccoli rispetto alla piegatura in aria, a parità di larghezza della matrice, materiale e spessore. Ne consegue un minor ritorno elastico e la necessità di prevedere sviluppi leggermente più lunghi rispetto
all’omologa matrice in aria. Non prevede grandi aumenti di forza di piegatura e si rivela essere una buona soluzione anche per piegare materiali estetici quali l’Aisi 304 protetto.
Coniatura
Rappresenta una modalità sempre più in disuso, ma che può ancora oggi fornire dei grandi vantaggi in condizioni particolari. Come suggerisce il nome “coniatura” prevede lo “stampaggio del materiale” che viene forzato fino ad assumere la forma del punzone e della matrice adottati: in questo caso, infatti, entrambi hanno una apertura di V= 90°.
Per una effettiva coniatura è necessaria una forza di almeno 4,5 volte superiore a quella in aria. Il ritorno elastico del materiale viene annullato, con il conseguente ottenimento di una grande costanza nei gradi delle pieghe. I limiti sono principalmente due: si possono ottenere al massimo pieghe a 90° e, data la grande pressione necessaria, si possono coniare lamiere aventi spessori massimi di 1,5 / 2 mm in acciaio al carbonio o inossidabile.
Note
- ^ come calcolare il fattore k della lamiera, su vicla.eu.
Bibliografia
Pieghe d'Arte - Arte e Tecnica della Pressopiegatura[1]
Voci correlate
- Lamiera
- Stampaggio
- Tranciatura
Altri progetti
Altri progetti
- Wikizionario
- Wikimedia Commons
 Wikizionario contiene il lemma di dizionario «piegatura»
Wikizionario contiene il lemma di dizionario «piegatura» Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su piegatura
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su piegatura
 Portale Ingegneria
Portale Ingegneria Portale Materiali
Portale Materiali Portale Scienza e tecnica
Portale Scienza e tecnica- ^ Presse piegatrici per lavorazione lamiera Made in Italy, su www.vicla.eu. URL consultato il 13 giugno 2024.